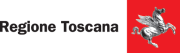L'impatto del cosiddetto "greening" sulla mortalità in Italia
Esempi di greening (rinverdimento): rigenerazione delle aree urbane (trasformazione di ex zone industriali in parchi urbani), soluzioni innovative in edifici già esistenti (tetti verdi e giardini verticali), riorganizzazione del traffico e riallocazione dello spazio stradale a favore di aree verdi, incremento di alberi lungo le strade.
Il greening è quel processo che porta a rendere più verde un’area, piantando piante e alberi. A dicembre 2024 su Nature Communications è stato pubblicato l’articolo The mortality impacts of greening Italy a cura di un gruppo di epidemiologi italiani - Giannico, Sardone, Bisceglia, Addabbo, Pirotti, Minerba e Mincuzzi - che hanno analizzato l’impatto del greening sulla mortalità nelle città italiane.
Esempi di greening (rinverdimento) includono la rigenerazione delle aree urbane (trasformazione di ex zone industriali in parchi urbani), soluzioni innovative in edifici già esistenti (tetti verdi e giardini verticali), la riorganizzazione del traffico e la riallocazione dello spazio stradale a favore di aree verdi e naturali, nonché l’incremento di alberi lungo le strade.
È ampiamente dimostrato che gli spazi verdi apportano benefici sulla salute umana, ma quantificare tali benefici rappresenta una sfida per l’epidemiologia. Nel presente studio, gli autori hanno utilizzato i dati satellitari per stimare il numero di decessi che potrebbero essere evitati nella popolazione adulta italiana attuando un processo di greening delle aree residenziali.
A livello politico, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda che sia disponibile un minimo di 0,5 ettari di spazio verde entro una distanza lineare di 300 metri da ogni abitazione. Il principio 3–30–300 per il rinverdimento urbano, proposto da Cecil Konijnendijk, stabilisce che ogni casa, scuola e luogo di lavoro dovrebbe avere almeno tre alberi vicini ben visibili; ogni quartiere dovrebbe avere almeno il 30% di copertura arborea; e ogni abitazione dovrebbe trovarsi a non più di 300 metri dal più vicino grande spazio verde pubblico.
Nello studio di Giannico e colleghi, che qui presentiamo, è stato usato l’indice di vegetazione normalizzato (NDVI), una metrica derivata dall’uso dei satelliti, ampiamente utilizzata per quantificare la vegetazione negli insediamenti umani (ad esempio, alberi lungo le strade o vegetazione generica in spazi pubblici e privati) ed è stato dimostrato in diversi studi la relazione inversa tra NDVI e mortalità. Si è cercato quindi di stimare il numero di decessi che potrebbero essere evitati in Italia aumentando il verde nelle aree residenziali e portandolo allo stesso livello di cui gode già il 25% della popolazione. L’esposizione è stata valutata entro una distanza di 300 metri dalle abitazioni, sfruttando immagini satellitari con risoluzione a 10 metri.
Il carico totale stimato della mortalità su tutta la popolazione italiana (circa 49 milioni di persone) varia da circa il 2,1% nei comuni meno popolosi al 6,3% dei capoluoghi di provincia. Questi risultati sono anche coerenti con le proporzioni stimate di copertura arborea e di aree verdi per ciascun gruppo di comuni.
L’esposizione al verde non include solo la disponibilità di spazi verdi, ma anche la sua distribuzione spaziale in relazione alla popolazione, per esempio, aree verdi lontane dalle abitazioni non contribuiscono all’esposizione residenziale. A differenza di precedenti studi sulla valutazione di impatto sanitario (HIA) che fissavano obiettivi differenti per ciascuna città, nel presente studio è stato utilizzato un unico NDVI, al fine di garantire la confrontabilità delle stime.
L’analisi dei dati sulla copertura del suolo condotta in questo studio, evidenzia il ruolo fondamentale degli alberi nelle aree residenziali in Italia. La presenza di alberi è associata alla riduzione di molti fattori nocivi come, il calore eccessivo, l’inquinamento atmosferico, ma hanno anche un impatto positivo sulla salute mentale, sulla riduzione dello stress e l’umore e sul sistema immunitario.
La morbilità legata al calore nelle città rappresenta una seria preoccupazione per la salute pubblica, infatti l’effetto isola di calore urbana può comportare rischi significativi per la salute. Gli spazi verdi urbani possono mitigare gli effetti del caldo, gli alberi possono offrire ombra e ridurre la necessità dei condizionatori d’aria e, nei paesi più caldi, fornire spazi esterni confortevoli.
Entrando nel dettaglio del metodo qui usato, l’analisi dei dati e la visualizzazione sono state fatte utilizzando Google Earth Engine R. L’area di studio comprende tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione o popolazione. Per l’anno 2022, l’elenco ISTAT includeva 7.904 comuni: 109 capoluoghi di provincia e 7.795 comuni non capoluogo, la popolazione adulta residente era pari a 48.628.328, di cui 14.530.259 residenti nei capoluoghi di provincia e 34.098.069 nei comuni non capoluogo.
I punti di forza dello studio di Giannico e colleghi sono: l’inclusione di tutti i comuni e dell’intera popolazione; l’utilizzo di dati satellitari ad altissima risoluzione per valutare l’esposizione; calcolo ponderato della popolazione, al fine di tenere conto delle differenze nella distribuzione spaziale della popolazione nelle varie zone; l’utilizzo di dati recenti; l’impiego di dati di mortalità specifici per città e per fasce d’età; l’applicazione di numerose analisi di sensibilità su popolazione, obiettivi, funzioni, formule e modelli statistici.
In conclusione è stato stimato che, portando il grado di verde residenziale attualmente raggiunto dal 25% della popolazione a livello nazionale, si potrebbero evitare in totale 28.433 decessi all’anno, con un tasso annuale prevenibile pari a 71 ogni 100.000 abitanti (IC al 95%: 54-106). Nello specifico, il numero stimato di decessi annui evitabili è pari a 12.377 (IC 95%: 9317-18428) nei capoluoghi di provincia e a 16.056 (IC 95%: 12.083-23.923) nei comuni non capoluogo. Il tasso di mortalità prevenibile più elevato è stato stimato nei capoluoghi di provincia (86 decessi ogni 100.000 abitanti) e nei capoluoghi con popolazione pari o superiore a 120.000 abitanti (93 decessi ogni 100.000 abitanti).
Gli anni di vita persi (YLL) sono stati stimati in un totale di 279.324 (IC 95%: 210.247-415.980), con un tasso annuale di YLL pari a 702 ogni 100.000 abitanti. Il numero stimato di YLL prevenibili all’anno è pari a 118.257 nei capoluoghi di provincia e a 161.066 nei comuni non capoluogo. Il tasso più elevato di YLL prevenibili è stato stimato nei capoluoghi di provincia (826 YLL ogni 100.000 abitanti) e nei capoluoghi con una popolazione pari o superiore a 120.000 abitanti (893 YLL ogni 100.000 abitanti).
Inoltre, il metodo qui usato è facilmente replicabile senza la necessità di georeferenziare la popolazione locale. L’approccio consente di stimare l’esposizione a livello comunale utilizzando dati pubblici su esposizione e popolazione, disponibili gratuitamente in tutto il mondo ad alta risoluzione. Le informazioni richieste su mortalità e popolazione sono aggregate a livello comunale. Utilizzando i dati statistici più recenti, l’HIA può essere replicato a livello globale. Inoltre, l’implementazione di diverse analisi di sensibilità consente di confrontare gli impatti valutati con metodi e scenari differenti.
Per saperne di più:
-
Giannico OV, Sardone R, Bisceglia L, Addabbo F, Pirotti F, Minerba S, Mincuzzi A, (2024). The mortality impacts of greening Italy. Nature Communications, 15:10452